|
interpreti: - Emily Watson - Stellan Skersgard - Katrin Cartlidge - Jean-Marc Barr - Adrian Rawlins |
sceneggiatura: Lars Von Trier fotografia: Robby Muller Danimarca 1996 durata: 158' |
 Elemento questo che complica e non semplifica il compito
critico di districarsi fra macchina narratologica, costruzione
scenografica ed ipoteca ideologica di Von Trier, perchè nulla
in questo film appartiene all'ortodossia della fede (e nemmeno a quella
tutta laica dello spettatore e delle sue attese di rigore logico e di
costruzione formale).
Elemento questo che complica e non semplifica il compito
critico di districarsi fra macchina narratologica, costruzione
scenografica ed ipoteca ideologica di Von Trier, perchè nulla
in questo film appartiene all'ortodossia della fede (e nemmeno a quella
tutta laica dello spettatore e delle sue attese di rigore logico e di
costruzione formale).
 Tutto è concepito ad "illustrare" (nel senso che la
retorica cristiana concepiva) la vita della "santa". Che
lo è in virtù della sua fede nell'assurdo (ed in ciò
siamo teologicamente più vicini all'ipotesi
protestante-esistenzialista): l'assurdo dell'amore
orizzontale, quello degli uomini per gli uomini, non
degli uomini per Dio.
Tutto è concepito ad "illustrare" (nel senso che la
retorica cristiana concepiva) la vita della "santa". Che
lo è in virtù della sua fede nell'assurdo (ed in ciò
siamo teologicamente più vicini all'ipotesi
protestante-esistenzialista): l'assurdo dell'amore
orizzontale, quello degli uomini per gli uomini, non
degli uomini per Dio.
 Von Trier nasconde tutto sotto la categoria del Miracolo,
che è il culmine storico di ogni vita dei santi che si rispetti, e
che è destinato a spiazzare ulteriormente l'attesa dello spettatore
(cosa che puntualmente avviene: la sala generalmente accoglie con cinica
ilarità lo scampanìo finale...).
Von Trier nasconde tutto sotto la categoria del Miracolo,
che è il culmine storico di ogni vita dei santi che si rispetti, e
che è destinato a spiazzare ulteriormente l'attesa dello spettatore
(cosa che puntualmente avviene: la sala generalmente accoglie con cinica
ilarità lo scampanìo finale...).
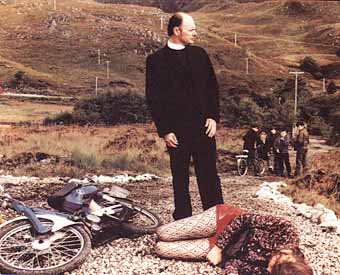 Potenzialmente, il debito autorale che Von Trier paga a se stesso (ai film
cioé come "L'elemento del Crimine" che ritorna qui
nella scelta coloristica e nel sovraccarico simbolico) contribuisce ad
appesantire forse la capacità comunicativa dell'opera, come il gioco
a lungo andare eccessivo, dei raccordi di scena volutamente evidenti, o
della steadycam che insegue le persone (non i personaggi, perchè
anche la figura di Jan, un sobrio Stellan
Skarsgard, rimane volutamente stilizzata: essi rifluiscono in
quella cornice cui accennavamo come appunto il tempo storico o la
"folla" nel genere agiografico si ritira a pura
"occasione" dell'agire del santo) e simbolicamente la allontana
mettendole fuori fuoco (segnalando l'urgenza di Von Trier
di entrare fisicamente nel film), ed infine la sgranatura delle
immagini che marca emotivamente le situazioni (interni ed esterni:
nel caso della chiesa anche il carico coloristico).
Potenzialmente, il debito autorale che Von Trier paga a se stesso (ai film
cioé come "L'elemento del Crimine" che ritorna qui
nella scelta coloristica e nel sovraccarico simbolico) contribuisce ad
appesantire forse la capacità comunicativa dell'opera, come il gioco
a lungo andare eccessivo, dei raccordi di scena volutamente evidenti, o
della steadycam che insegue le persone (non i personaggi, perchè
anche la figura di Jan, un sobrio Stellan
Skarsgard, rimane volutamente stilizzata: essi rifluiscono in
quella cornice cui accennavamo come appunto il tempo storico o la
"folla" nel genere agiografico si ritira a pura
"occasione" dell'agire del santo) e simbolicamente la allontana
mettendole fuori fuoco (segnalando l'urgenza di Von Trier
di entrare fisicamente nel film), ed infine la sgranatura delle
immagini che marca emotivamente le situazioni (interni ed esterni:
nel caso della chiesa anche il carico coloristico).
Tutto ciò può avvolgere a spirale (e lo fa) la potenzialmente
infinita analisi critica del film, anche se ad ogni giro di spirale si ha
la sensazione di allontanarsi dal cuore mercé il voluto depistaggio
del regista: come se Von Trier costringesse (più ancora che nel
barocco "L'elemento del crimine") a misurarsi con tutto il
farraginoso armamentario dell'ermeneutica per poi essere costretti (come
nel nostro caso) a deporlo. E a rimanere fastidiosamente prigionieri di
questo amore così risolutamente orizzontale da costringere un Dio a
nascere per sottrarlo al maltrattamento della meschina storia degli uomini.
Leonardo (16-11-1996)
|
[Indice] [Aiuto] |
[Cos'è DM]
[Chi è DM]
[Storie] [Recensioni] [Visioni] [Letture] |
[HomePage] [Tempozero] |